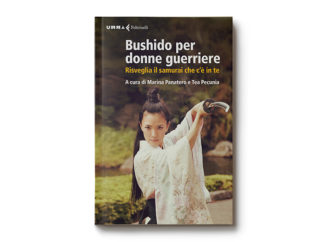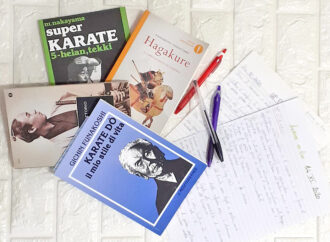Il karate olimpico e/o sportivo è figlio del regolamento e delle scelte degli atleti più rappresentativi del momento.
Quasi tutti almeno una volta abbiamo desiderato che il karate diventasse disciplina olimpica. In nome di questo sogno 42 anni fa, il 17 dicembre 1978, si sciolse la Fesika, per fondersi con la Fik e ottenere l’agognato riconoscimento del Coni, preludio di quell’unificazione internazionale che avrebbe dato al karate le carte in regole per chiedere al CIO l’agognato riconoscimento. Ricordo la resistenza di molti e la commozione del M° Shirai, che disse che la sua aspirazione era veder sventolare il tricolore sul podio. Chi scrive intraprese negli anni Ottanta la carriera arbitrale, per seguire i propri atleti e comprendere meglio le regole del “combattimento sportivo” (per il kata valevano le “nostre” regole, anzi fu grazie a noi che il kata debuttò nel 1979 ai campionati europei Uek di Helsinki, con le medaglie d’oro di Rossano Ruffini e Cristina Rissone).
Nessuno di noi, al momento dello scioglimento della Fesika e nel corso del decennio successivo, nel quale coabitarono nella stessa federazione due visioni diverse della stessa disciplina, avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto aspettare quasi mezzo secolo per assistere al debutto del karate alle Olimpiadi e, ancor meno, quanto il “karate olimpico” sarebbe stato distante, sia dalla disciplina che avevamo sempre praticato sotto la guida del M° Shirai, sia dalla versione, meno ortodossa ma pur sempre riconoscibile, che avevamo visto in azione nei vari campionati italiani, europei e mondiali negli anni Ottanta. In quel periodo, con qualche adattamento nel regolamento arbitrale, si confrontavano atleti di diversa provenienza e formazione: per intenderci, ai mondiali IAKF del Cairo nel 1983 la finale del kumite individuale era stata tra Yamamoto (Jka) e Claudio Guazzaroni (ex Fik).
Stupore e perplessità comprensibili in praticanti e maestri che non hanno preso atto della “mutazione” progressiva del karate sportivo.
Raccogliendo sul web i commenti di chi ha seguito da lontano il torneo olimpico di karate, ho visto incredulità, sgomento e perfino sdegno, soprattutto da parte di chi (è il caso della maggior parte dei “tradizionalisti”) non ha seguito negli ultimi anni il circuito della cosiddetta “Premier League” e i vari campionati europei della WKF, sospesi causa pandemia nel febbraio 2020 e ripresi poco prima dell’inizio delle Olimpiadi. Stupore e perplessità comprensibili in praticanti e maestri che non hanno preso atto della “mutazione” progressiva del karate sportivo negli ultimi due decenni. Scrive ad esempio il M° Ludovico Ciccarelli, responsabile del settore “tradizionale” della Fesik:
«Ma di che Karate si tratta? Nel kata un insieme di movimenti che non rappresentano l’espressione (che dovrebbe essere la parte più “pura”) della forma, bensì un esercizio di esibizione teatrale con pause volumizzate e tecniche che non riflettono il significato e il senso del kata stesso. Nel kumite invece troviamo lotta, strattonate, buttarsi addosso all’avversario, tecniche monche, saltelli isterici ecc., ma le tecniche di karate dove sono? Ora qui non è più un discorso di differenziazione tra Karate sportivo e tradizionale, è solo una questione di buon senso e di riconoscere che il karate “olimpico” sta insinuandosi in un imbuto che tende a chiudersi sempre più, senza alcuna via d’uscita. Vedere il karate alle Olimpiadi ridotto come la scherma, più o meno, non è bel segnale per nessuno. Una cosa è certa: a noi (e siamo tanti) questo Karate non piace.»
Per rispondere a domande e obiezioni ho pensato di consultare due amici che più di me sono stati a stretto contatto con il karate “made in Fijlkam”: Maurizio Cavallari, già allievo del M° Carlo Pedrazzini e campione delle Fiamme Gialle, che un paio di anni fa si è allenato con l’iraniano Ganjzadeh, medaglia d’oro a Tokyo, e Claudio Albertini, il primo maestro di Viviana Bottaro. Ecco, in sintesi, cosa mi hanno raccontato, con accenni a volte critici verso scelte arbitrali poco chiare o discutibili.
A Maurizio ho chiesto in particolare le ragioni dell’introduzione del corpetto protettivo e dell’abolizione quasi totale dello yame, con la conseguenza che gli atleti spesso si rifugiano in “clinch” e si sferrano colpi di dubbia efficacia da breve distanza. Non gli ho chiesto perché per vincere un incontro prima del termine sia oggi richiesto un vantaggio di ben 8 (otto) punti sull’avversario, perché lo sapevo già: la regola viene dal taekwondo ed è stata adottata perché qualcuno ritiene più spettacolare una vittoria 9 a 7 che 1 a 0. Naturalmente il criterio del todome (colpo risolutivo) da queste parti è morto e sepolto!
Sul kumite lascio la parola a Maurizio Cavallari:
«L’introduzione del corpetto non so bene quando sia stata effettuata. Mi hanno detto che l’ha suggerita il professor Aschieri. Che cosa c’entri il corpetto dove non c’è KO, devo ancora capirlo. Ai nostri tempi gli gyaku-tzuki alle costole fluttuanti erano da evitare accuratamente o da dare eventualmente per mettere in crisi la sicurezza dell’avversario. Il corpetto… mah!!? Un’altra notizia che ho, ma che andrebbe verificata, è che la proibizione di afferrare con tutte e due le mani il kimono dell’avversario per proiettarlo sia stata introdotta su iniziativa di Davide Benetello, quale membro della commissione atleti della WKF. Questo mi sembra sia successo una decina di anni addietro, dopo che alcuni atleti, per esempio Aghayev, venendo dalla lotta e dal Sambo, facevano delle proiezioni che a corta distanza erano sempre molto efficaci.
Ci sarebbe poi da dire sul ritardo dello yame, che arriva quando gli atleti si trovano già a corta distanza. Sono scelte regolamentari, ma il combattimento ne viene fortemente influenzato. Ricordo che ai miei tempi dopo lo scontro o la tecnica era valida, oppure veniva dato lo yame, quasi subito. La decisione di lasciare continuare il combattimento senza fermarlo ha fatto sì che a corta distanza gli atleti vengano limitati nelle tecniche, per esempio nelle proiezioni a due mani o con una mano sotto la gamba, ciò per contentare i lottatori di lotta libera o di Sambo provenienti soprattutto dall’Est. Da un lato si lasciano avvicinare gli atleti, dall’altro si limitano le tecniche. Gli tzuki da cortissima distanza mi chiedo che efficacia possano rappresentare, o che zanshin abbiano.
Un aneddoto: ricordo ancora inorridito quando, intorno all’anno 1999 o 2000, assistetti a una finale dei campionati italiani della Fijlkam sul lago d’Iseo. Gli atleti, al fine di far fermare l’incontro con lo yame, si mettevano vicini, quasi dovessero sfiorarsi le fronti o darsi un bacetto. Dopo due o tre secondi circa, l’arbitro chiamava lo yame. Ricordo che in quell’occasione ci ritrovammo tra alcuni vecchi atleti quali Massimo Di Luigi, Claudio Guazzaroni, Gianluca Guazzaroni, Angelo Falco, Franco D’Agostino, Andrea Lentini e altri ex delle Fiamme Gialle e dei Carabinieri. Il commento fu abbastanza unanime nel dire che, se un atleta nel combattimento venisse vicino così, prenderebbe – se gli va bene – una testata diretta in faccia. Perché noi eravamo nati e cresciuti con un karate che aveva nell’efficacia dei colpi, teorica ma controllata, il suo punto di forza. Per cui era un po’ come la scherma: c’è l’assalto, chi arriva prima ha fatto il punto perché ha portato una tecnica molto pericolosa ed efficace.
Lo yame veniva dato appena finito lo scontro a distanza “utile”. Era impensabile immaginare, per noi di quell’epoca, che un avversario potesse venire vicino alla mia testa, corpo a corpo, e non succedesse nulla. La stessa cosa immagino se qualcuno fosse andato a fare quel giochetto del “bacetto” a combattenti come Codrington, Thompson, Charles, Koetzebue, Carbilla, Pinda, Royers, Brennan, Yamamoto, Tanaka e altri. Sia nella JKA, sia nella Wuko, ti mandavano tutti direttamente all’ospedale. Era un concetto più vicino al combattimento reale, anche se ritualizzato ed elevato nel significato simbolico con le regole del controllo. Quindi, già 20 anni fa si assisteva a questo regolamento che non si sa bene cosa cercasse. Tecnica? Spettacolo? Incolumità? Non so dirtelo.»
Se il regolamento del kumite è largamente responsabile delle stranezze e delle brutture di cui parla anche il M° NandoBalzarro, “Ho visto contendenti tirarsi per la giacchetta, tirare colpi fuori distanza – troppo corta o troppo lunga – calci senza stabilità e fuori bersaglio”, altrettanto non si può dire per il kata.
Nel kata le uniche due novità degli ultimi anni, come mi ha confermato il M° Claudio Albertini, sono la disposizione in linea di tutti gli arbitri, “non facilita la visione di quanto accade quando l’atleta volta le spalle alla giuria”, e l’unificazione dei criteri di giudizio, che ora sono ridotti a due: tecnica (che vale il 70% del punteggio complessivo) e atletica, che vale il 30%. La valutazione tecnica comprende le posizioni, le tecniche, le transizioni, il ritmo, la respirazione, il kime e la “conformità” allo stile; la valutazione tecnica include forza, velocità ed equilibrio. In nessun modo il regolamento prescrive la lunghezza delle pause o la necessità di “fare una faccia cattiva” e, come avrete notato, non c’è una voce “espressività”. C’è invece il richiamo, largamente disatteso, a evitare perdite di tempo, ad esempio con “marce prolungate, inchini eccessivi, pause prolungate prima di iniziare il kata”. Il regolamento WKF stabilisce che “il kata non è una danza o rappresentazione teatrale. Deve aderire ai valori e ai princìpi tradizionali. Deve essere realistico in termini di combattimento”. Francamente, non tutti i kata visti a Tokyo rispettano lo spirito e la lettera del regolamento. Certamente li rispetta il vincitore, Ryo Kiyuna.
Naturalmente il criterio del todome (colpo risolutivo) da queste parti è morto e sepolto!
In buona sostanza, il modo di eseguire i kata nella WKF (e di conseguenza alle Olimpiadi) come “un esercizio di esibizione teatrale con pause volumizzate e tecniche che non riflettono il significato e il senso del kata stesso” (Ciccarelli) sembra una moda del momento, si spera passeggera, e non descrive tutte le esibizioni viste a Tokyo. Ma anche nel kumite, nonostante i problemi qui evidenziati, va a tutto merito degli atleti in gara se numerosi combattimenti hanno evidenziato tecnica e spirito, e sarebbero stato apprezzati anche in un contesto più marziale. Penso all’epico scontro Abdulaziz–Nishimura, senza esclusione di colpi, conclusosi 8-7 per il giapponese, o alla finale in cui la giovane bulgara Goranova ha nettamente battuto la favorita Anzhelika Terliuga.
Il karate olimpico (e sportivo in generale) è figlio del regolamento e delle scelte degli atleti più rappresentativi del momento: non ci sarebbe da stupire se, con un’entrata più massiccia di scuole legate alla tradizione, il livello migliorasse e diventasse più simile, in termini di marzialità e di purezza tecnica, a quello a cui i nostri maestri e migliori atleti ci hanno abituati in passato.